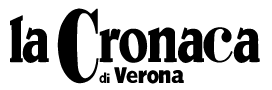Visto quanto ho scritto in precedenza, sull’arte bizantina e sul passaggio al gotico internazionale, cercherò di descrivere ora la scrittura di icone (non ”pittura”, come spesso si dice), una pratica artistica ma soprattutto spirituale antichissima, che affonda le radici nella tradizione cristiana orientale, in particolare bizantina e russa. Le icone, così ormai nominate per semplicità, anche se icona significa genericamente immagine, ha un suo senso teologico e simbolico, sia gli aspetti tecnici e materiali del processo della sua realizzazione. L’icona, a differenza di ciò che spesso erroneamente si pensa, non è una semplice immagine sacra, ma viene considerata una teofania, una manifestazione visibile dell’invisibile. Per questo in modo corretto si dice che l’icona si scrive, non si dipinge perché è ”Parola di Dio in forma visiva”, un Vangelo dipinto. L’iconografo non è considerato semplicemente un artista nel senso moderno, ma un testimone o servo del mistero. Prima di lavorare, l’iconografo si prepara con il digiuno e la preghiera, chiedendo di diventare strumento dello Spirito Santo. A questo proposito ricordo un bellissimo viaggio al monte Athos dove conobbi un monaco iconografo che alla sera tardi illuminato solo dalla luce di una candela scriveva le sue icone continuando a pregare. L’importanza dell’opera sta anche nel fatto che ogni gesto e colore ha un significato simbolico e teologico preciso. L’icona è destinata alla preghiera, non alla decorazione, e viene posizionata nell’angolo ”bello” della casa. Per scrivere un’icona si utilizza legno stagionato, spesso di tiglio, pino o cipresso e tutti materiali naturali. Sul retro è talvolta incassata una ”cerniera” o traverse per evitare deformazioni. La superficie è preparata con tela di lino incollata e diversi strati di gesso (gesso di Bologna + colla animale), levigati fino a ottenere una base liscia e assorbente. Il disegno preparatorio si traccia con precisione, a volte copiando modelli canonici detti prototipi, poiché ogni soggetto sacro ha una tradizione iconografica precisa. I colori sono pigmenti naturali in polvere mescolati con tuorlo d’uovo e acqua: la tempera all’uovotecnica questa, che permette tinte sottili, trasparenti e durature. Prima della pittura vera e propria, si applica il bolo armeno (argilla rossa + colla) sul fondo, dove verrà poi posata la foglia d’oro (simbolo della luce divina increata). L’oro poi viene lucidato con agata o lasciato opaco, a seconda della tradizione. La logica dell’icona non essendo, come già detto un semplice dipinto, è teologica, non naturalistica. L’idea sottesa alla realizzazione di una icona, e’ il passaggio dal buio alla luce: si parte da tonalità scure (materia) per giungere progressivamente alle luci (divinizzazione). Non esiste una sorgente di luce naturale: la luce viene da dentro l’immagine. E’ la Luce dello Spirito, non la luce solare quella che illumina le figure. L’oro rappresenta la Luce Divina, I eternità. Tra i soggetti maggiormente rappresentati ci sono: II Cristo Pantocratore – II Signore onnipotente, al centro della teologia dell’icona. La Theotokos (Madre di Dio) Spesso rappresentata con il Bambino, simbolo dell’Incarnazione. I Santi e martiri, secondo la tradizione liturgica. Le Scene evangeliche Annunciazione, Trasfigurazione, Crocifissione, Risurrezione. Ogni soggetto ha modelli canonici stabiliti dai concili e tramandati nei manuali, come I”Erminia” di Dionisio di Furna (XVIII secolo), ancora oggi testo fondamentale per gli iconografi ortodossi. (Dionisio da Furnà stato un pittore e monaco cristiano greco, particolarmente noto per aver redatto l’Ermeneutica della pittura, un manuale che rappresenta un ricco compendio di norme iconografiche.