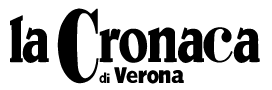In diverse occasioni, parlando di opere ed artisti veneti e veronesi nello specifico, abbiamo avuto modo di incontrare tra coloro che hanno avuto la capacità in influenzare il rinascimento italiano, la figura di Durer il cui grande merito fu quello di unire due tradizioni lontane e rinnovarle. Tra gli artisti maggiori del XVI secolo, viene considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale. A Venezia l’artista entrò in contatto con ambienti neoplatonici. Si presume che tali ambienti abbiano sollevato il suo carattere verso l’aggregazione esoterica. Dürer, pittore e incisore tedesco (Norimberga), conobbe e ammirò l’arte italiana. Nelle sue opere combinò la prospettiva e le proporzioni rinascimentali con il gusto tipicamente nordico per il realismo dei dettagli. I volti, i corpi e gli abiti dei suoi personaggi sono raffigurati con minuziosi particolari, gli ambienti sono descritti in maniera realistica e gli spazi sono chiari e ordinati grazie a una precisa griglia prospettica. La grandezza di Dürer, venne riconosciuta da subito, lui ancora in vita, dai contemporanei come fu scritto sulla sua lapide dal suo migliore amico Willibald Pirckheimer, quelle poche parole che lo consacrarono definitivamente al regno dei Grandi: «Ciò che di mortale fu di Albrecht Dürer riposa in questa tomba». Nell’ultimo periodo della sua vita scrisse trattati d’arte e matematica per dimostrare che il buon artista non era solo un artigiano, ma che doveva avere un solido bagaglio culturale, tecnico e filosofico. Il suo grande desiderio era nobilitare la figura dell’artista e renderlo un uomo in grado di confrontarsi con il suo tempo. Nel 1513 aveva realizzato una delle sue stampe più celebri: «Il cavaliere, il diavolo e la morte». L’incisione a bulino mostra un cavaliere che avanza sicuro, protetto dalla sua armatura di fede, in una gola rocciosa abitata dai più grandi nemici dell’uomo: si è già lasciato alle spalle il demonio, inciso nell’aspetto di animale fantastico e cornuto, e nemmeno degna di uno sguardo la morte che tenta di spaventarlo poggiando sulla criniera del cavallo una clessidra a monito della vita rimastagli. Molti hanno interpretato l’opera con la crisi del Cattolicesimo, insidiato dalle lusinghe del potere e della ricchezza. L’abilità di Durer incisore si mostra nei dettagli naturalistici, nella ricchezza dei particolari, nella resa atmosferica del secondo piano, che lascia la città, lontana sul picco, come avvolta da un velo di nebbia. Non mancava mai di mettere la sua firma: il celebre monogramma con le iniziali A e D, che sarà sia uno dei dettagli che lo renderanno tanto riconoscibile quanto falsificato. Il suo bellissimo autoritratto del 1500 come ”Salvator mundi” creò tante polemiche dentro la chiesa che vide un atto di arroganza quel suo ritrarsi così simile a Cristo. Durer voleva invece mostrare come tutti gli uomini potessero, anzi, somigliassero al figlio di Dio fatto uomo, anticipando quei sentimenti di contatto diretto con la divinità. Ma la sete di conoscenza e la curiosità non potevano trattenerlo dal confrontarsi con la grande pittura, quella fiamminga e soprattutto quella italiana, dopo i viaggi che intraprese tra gli anni ’90 del Quattrocento e il primo decennio del secolo successivo. Soprattutto durante il soggiorno veneziano, gli si aprì un mondo ancora ignoto agli artisti d’oltralpe, quello della classicità, dell’umanesimo italiano. Nel dipinto: la «Festa del Rosario», per la chiesa di San Bartolomeo a Rialto nel 1506, durante il secondo viaggio in Italia, Durer rappresenta bene il momento in cui due delle maggiori scuole europee si fondono nell’opera di uno solo. Nell’opera, rielaborò modelli già di Giovanni Bellini, fondendoli con il luminoso cromatismo nordico, una luce quasi abbagliante che permette di indagare l’accurata resa dei dettagli e delle fisionomie, veri e propri ritratti.