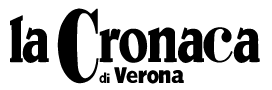La sensazione crescente di insicurezza, legata ai tanti casi di cronaca nera, può condizionare la salute mentale, sia nostra che delle persone a cui teniamo. L’esposizione continua a storie di violenza, alcune del tutto slegate da un senso (anche se «un senso non c’è mai» cit. Vasco) come l’accoltellamento ai danni di una donna di Milano «scelta a caso» dal suo aggressore, può aggiungere un «carico emotivo» anche in chi non è coinvolto. I più colpiti da questo sono: donne, anziani, persone vulnerabili, persone residenti in aree percepite come insicure e persone molto esposte ai media o isolate socialmente. In generale, non serve essere direttamente vittima di un crimine perché l’insicurezza percepita e la sensazione del «potrebbe capitare anche a me» producano un effetto negativo sulla salute mentale. Una Meta-analisi (realizzata su 63 studi clinici) ha evidenziato che livelli più elevati di criminalità percepita, o reale, nel quartiere dove si vive sono associati a maggiore depressione, ansia, distress psicologico anche in persone che non sono state direttamente vittime di eventi violenti. Allo stesso tempo, è stato osservato che la resilienza individuale (come avere buone relazioni sociali) può attenuare l’impatto negativo della criminalità locale sulla mente. La letteratura ci dice che lo «stare nella paura» (fear of crime) è collegato a un peggioramento della salute mentale e fisica. Il convivere nella paura comporta una carrellata di ripercussioni. Ansia costante: preoccupazione di uscire di casa, di mandare i figli fuori da soli, di non essere al sicuro… Questa iper-vigilanza può affaticare chi la prova e avere una ricaduta anche sui familiari: quando un genitore è molto angosciato, anche i figli lo percepiscono; possono percepire una tensione e sentirsi meno liberi di distaccarsi, avere a loro volta timore di «qualcosa» di non ben definito. Disturbi del sonno: pensieri intrusivi, disturbanti e ricorrenti, difficoltà a «staccare» il pensiero dopo aver letto di un altro episodio di cronaca nera. Evitamento: ridurre la socialità, scansare le uscite, cambiare abitudini può impoverire la vita quotidiana, fino a generare isolamento. Per mitigare l’impatto sull’umore e in generale sulla salute mentale diventa quindi utile limitare l’esposizione alle notizie che generano preoccupazione. Attenzione, questo non significa evitare la cronaca, ma gestirne il consumo. Inoltre, risulta utile condividere le emozioni: parlare con un amico e un familiare o contattate un professionista se la paura o l’ansia diventano persistenti. Altrettanto importante è poi, tornare con la mente al senso di controllo: per esempio, verificare le misure concrete che si possono adottare (sicurezza domestica, orari, accompagnamenti…) per contenere il senso di impotenza. Anche cercare di mantenersi attivi socialmente e fisicamente aiuta, in quanto l’isolamento tende a peggiorare l’ansia. Infine, non dimentichiamo di stare vicini ai più piccoli spiegando in modo adatto all’età cosa succede, rassicurandoli, evitando sempre che siano troppo esposti a immagini drammatiche. Diventa utile valutare un supporto di uno psicoterapeuta se l’ansia o la paura diventano tanto intense da interferire con la vita quotidiana.
Sara Rosa