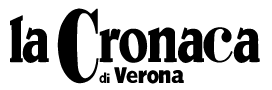«La bellezza salva e produce meraviglia. Per i greci la meraviglia era l’inizio di ogni conoscenza. Oggi abbiamo perso questa capacità, sappiamo solo capire cosa è utile, e non sappiamo più vedere che cosa è bello, che cosa è vero». Ospite, anche in questa edizione 2025, del Festival della Bellezza, Umberto Galimberti ha scelto, come è sua consuetudine, di prendere le mosse dalla civiltà dell’antica Grecia. Ricordando come la bellezza sia, di fatto, profondamente connessa al concetto di bene: «L’espressione kalòs kai agathos (καλός κάγαθός), bello e buono, indicava la stretta connessione tra l’aspetto estetico e la bontà, un’armonia, quindi, una sintesi perfetta di qualità estetiche e morali. E la bellezza, così come l’amore, si manifesta quando si mette fuori gioco la parte razionale. L’amore, in particolare, prevede il sacrificio e l’azzeramento dell’io». Diametralmente opposta alla bellezza, oggi, è la tecnica, quella che già più volte il filosofo ha definito il vero male del nostro tempo. Uno strumento fuori controllo: «Nel mondo oggi abbiamo una quantità di bombe atomiche tale da poter distruggere 20mila volte la terra, eppure si cerca ancora di migliorarla e si spende per questo». C’è quindi un non-senso, in questo momento storico, che Galimberti ha voluto rimarcare, non risparmiando la sua delusione nei confronti della società contemporanea. A partire dalla povertà di linguaggio che è sempre preludio di povertà di pensiero. «Sono le parole a generare i pensieri. Come possiamo pensare a qualcosa di cui non conosciamo il nome? Nascono così gli analfabeti emotivi». Chi ha già ascoltato il filosofo sa cosa aspettarsi. Evidentemente un ripasso può solo far bene, anche se la realtà sbattuta in faccia è sempre un doloroso promemoria. Galimberti ha accompagnato il pubblico in un viaggio nella storia, concentrandosi sul confronto tra la cultura greca e il cristianesimo, e su quell’angoscia della morte e paura del giudizio che gli antichi non avevano: «I greci, avendo fatto pace con la mortalità, riuscivano a cogliere la bellezza dell’esistenza. Io sono greco». Tanto è stato dedicato, anche in questo incontro, al ragionamento sull’etimologia delle parole, sul loro senso, e al contributo che i grandi uomini di cultura della storia hanno dato nei secoli per lo sviluppo del pensiero. Un pensiero che sembra essersi addormentato. Certo, essere colti significa investire tempo per la propria evoluzione. Significa leggere, ascoltare, approfondire. Azioni passate di moda, e a sostegno delle idee del prof arrivano i dati desolanti sulla cultura in Italia: «La gente non pensa più e, cosa ancora più inquietante, un ragazzo su tre sa leggere ma non è in grado di capire ciò che legge. Siamo di fronte a un vero collasso della cultura». Colpisce senza pietà il prof. Galimberti, e c’è poco da controbattere. Anzi, il pubblico lo ha applaudito a lungo martedi scorso, noncurante della pioggia e di un clima già autunnale al Teatro Romano. E rincara la dose: «Ma ve le devo dire io ste cose?», si chiede. Da parte nostra, noi ci chiediamo se davvero la platea sia poi in grado di dare un seguito ai pensieri scaturiti dal ragionamento del filosofo. Rivalutando, per esempio, l’importanza della cultura classica, dello studio del greco antico, dal quale derivano un’infinità di termini della nostra lingua italiana. O se, al termine della serata, dedicarsi a scorrere compulsivamente le bacheche dei social i giovani direbbero ”scrollare” senza aprire la pagina di un libro resti ancora la priorità.
ROSA FANI