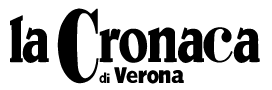“Vorrei dirti che non eri solo” – di Ilaria Cucchi
con Giovanni Bianconi
(2010, Rizzoli)
Lo scorso 14 novembre, la Corte d’Assise di Roma ha condannato a 12 anni di carcere, per omicidio preterintenzionale, due carabinieri imputati nel processo bis per la morte di Stefano Cucchi. In questo libro del 2010, la sorella Ilaria ripercorre quanto accaduto nei sei giorni intercorsi tra l’arresto e la morte di Stefano. Lo fa ricostruendo in parallelo anche la vita del fratello, senza paura di celarne le zone d’ombra e le fragilità.
UN PUGNO NELLO STOMACO. Leggerlo è un pugno nello stomaco. Non solo perché veniamo messi di fronte alla violenza inaudita e alla mancata tutela dei diritti nelle quali si è imbattuto Stefano. Il pugno nello stomaco è già nel titolo. Perché il tormento inconsolabile di Ilaria è nel non avere avuto modo di far sapere al fratello che non era stato abbandonato. Stefano è morto pensando di essere solo. Mentre i suoi genitori invece, aspettavano al di là di una porta, dove era stato loro detto di aspettare. Ritenevano di doversi attenere alle regole. Perché a quelle regole credevano, perché nelle leggi dello Stato che aveva in tutela il loro “bambino”, avevano fiducia. Per questo si sono mossi nello spazio delimitato dai vincoli della legge, aspettando che fosse troppo tardi, in un pellegrinaggio tra tribunale, carcere e ospedale, senza riuscire a vedere Stefano, perché mancava un documento, perché si frapponeva il fine settimana e con esso la chiusura degli uffici competenti.
IL SILENZIO. E nel frattempo, che è il tempo in cui loro vagavano per uffici e Stefano si spegneva, qualcuno è rimasto a tacere. Perché Stefano non valeva abbastanza. E questo non si può perdonare. Quando seppe della convalida dell’arresto, Ilaria pensò che in fondo “gli stava bene”. Che forse quella era la lezione che serviva a Stefano. Ilaria e i genitori, si sentivano forse anche responsabili, in difetto, non solo nei confronti di Stefano ma anche dello Stato. E lo Stato era rappresentato dai carabinieri, dalla polizia penitenziaria e infine dai medici del Pertini. Si sentivano in colpa ed erano dunque più vulnerabili. E’ stato facile quindi farli brancolare al buio come degli stupidi. E Stefano deve aver pensato che nessuno lo volesse più indietro.
TUTTI COINVOLTI. La storia di Stefano Cucchi, torturato a morte, riguarda noi tutti. Perché Stefano, al quale era stato contestato un reato, era nelle mani dello Stato, del nostro Stato, che lo aveva in custodia. E custodire significa “sorvegliare qualcuno/qualcosa con attenzione e con cura, in modo che non subisca danni e si preservi intatto”. Chiunque svolga una funziona di ordine pubblico, di sicurezza e di custodia deve sentire la responsabilità dell’essere il primo garante dell’inviolabilità di chi ha di fronte. Screditare l’immagine di Stefano, dire che “tanto era un drogato”, equivale a chiedere come fosse vestita la vittima di uno stupro, insinuare che in qualche modo se la sia cercata.
NON C’E’ ALIBI. Il vissuto di chi è sottoposto a custodia, così come qualsiasi suo comportamento o parola, non giustifica nessuna reazione violenta da parte dei rappresentanti delle istituzioni ai quali è affidato, e non può nemmeno costituire un’attenuante, perché ai soggetti che rappresentano lo Stato è chiesto qualcosa di più, il dovere istituzionale ed il peso morale della tutela della legalità e dei diritti umani.
LA SOLITUDINE. Nelle ore precedenti al decesso, Stefano scrisse una lettera ad un operatore della comunità in cui tempo addietro era stato ospite e in quelle righe sta la cifra della sua solitudine: “Sono al S. Pertini in stato d’arresto, scusami se ora sono di poche parole, ma sono giù di morale e posso muovermi poco. Volevo sapere se potevi fare qualcosa per me. Adesso ti saluto a te e agli altri operatori. P.S. Per favore almeno rispondimi.” L’ultima parte, Stefano, la scrisse in stampatello. PER FAVORE ALMENO RISPONDIMI. A Stefano non importava nemmeno quale sarebbe stata la risposta. Gli sarebbe bastato riceverne una. Perché una risposta, quale che sia, è la prova che qualcuno almeno ti sta ad ascoltare. Rileggete tutto questo adesso e immaginate che al posto di “Stefano” ci sia il nome di vostro fratello.
Giulia Tomelleri