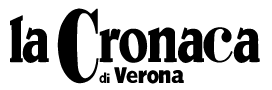Un periodo molto ricco dal punto di vista artistico e culturale a Verona, ma non solo, sarà quello che vede il passaggio dall’arte bizantina/italo-bizantina al Gotico Internazionale. Sarà un processo non sempre lineare, con tante contaminazioni, mutevoli rapporti culturali, politici e stilistici fra Oriente e Occidente. Verona mostrerà inoltre delle identità peculiari nel suo territorio anche per la presenza significativa della signoria degli Scaligeri, delle influenze lombarde e gotiche, e anche per l’arrivo di nuovi modelli artistici entro la cornice europea alla fine del Trecento e nel primo Quattrocento. Possiamo arrivare a dire che l’arte bizantina in Italia è la radice della pittura medievale italiana, fino all’arrivo di Giotto, che rivoluziona la rappresentazione con lo spazio e le emozioni, aprendo la strada al Rinascimento. Verona, nel Medioevo, è situata in un punto di incontro fra la sfera culturale lagunare/veneta, le influenze germaniche e le correnti provenienti dalla Lombardia. Dal punto di vista politico, la Signoria scaligera (Della Scala) rafforza il ruolo della città come centro di committenza, ricchezza, e apertura culturale. Verona ha anche momenti di autonomia artistica nonostante le dominazioni esterne. La tradizione bizantina era gia’ presente in Veneto (in particolare a Venezia), ma Verona non può essere considerato uno dei centri più fortemente «bizantini» nella forma dei mosaici, ma piuttosto nell’uso di modelli dell’iconografia sacra, in quella che è conosciuta come pittura miniata, nei rilievi e in certe «rigidità» stilistiche nella figura sacra, che risentivano ancora del modello bizantino. Per capire il passaggio dall’arte bizantina, a quella del gotico internazionale, è importante prima individuare come ho cercato di fare, cosa significava «arte bizantina / italo-bizantina» in area veneta/veronese. Nell’iconografia sacra come già accennato, le figure si presentano ieratiche, frontali, con poca profondità spaziale, prive di prospettiva. Le Madonne erano per lo più rappresentate in trono, i santi stilizzati, il fondo era dorato, occhi grandi, posa meditativa, ritmo statico. Influenze decorative saranno uso di marmi policromi, capitelli, colonne, ornamentazioni che richiamano l’arte delle architetture lagunari e delle esedre tardoromaniche con stile bizantineggiante. L’architettura romanica conservera’ elementi derivati dal mondo orientale benché con influenze lombarde e romaniche occidentali molto forti. A Verona, la basilica ad esempio di San Zeno è un capolavoro romanico, e pur non essendo puramente «bizantina» conserva un gusto per la decorazione, per la plasticità, per la monumentalità che anticipa certi aspetti successivi. Il cosiddetto Gotico Internazionale (o gotico tardivo / gotico cortese) si sviluppa a Verona tra circa il 1370 e il 1450. Verona, pur annessa alla Repubblica di Venezia nel 1405, conserva una forte identità culturale ed è ponte tra le influenze lombarde, tedesche, boeme, veneziane. Ciò la rende ricettiva agli stimoli stilistici del Nord e del Gotico Internazionale. Le opere di Stefano da Verona (fine Trecento-inizio Quattrocento) e di Pisanello sono tra i principali vettori di questo stile nella città. La Madonna del Roseto ad esempio (c. 1420-1435) conserva atmosfere raffinate, eleganti, favolistiche, tipiche del Gotico Internazionale. Anche affreschi come San Giorgio e la Principessa nella chiesa di Sant’Anastasia mostrano la «favola cortese», lo stile fiabesco e decorativo, l’eleganza formale, l’attenzione ai dettagli naturali, agli abiti, agli animali, al paesaggio. Le Arche Scaligere: architettura funeraria gotica monumentale, decorazione elaborata, slancio verticale, pinnacoli, baldacchini. È un esempio architettonico dell’espressione gotica piena in Verona. Il Duomo di Verona in origine romanico, poi subisce attraverso vari rimaneggiamenti gotici, anche negli interni, elementi gotici nelle cappelle, nelle finestre, e nella facciata Il Gotico Internazionale consente a Verona di inserirsi maggiormente nelle reti artistiche europee del tempo: artisti viaggiano, modelli visivi circolano; la città partecipa non solo all’arte locale ma al dialogo europeo. Raffinamento estetico e decorativo diventano parte del prestigio civico oltre che religioso. Si impone una pratica pittorica più naturalistica, uno studio del paesaggio, della luce, dei dettagli, che anticipa in un certo senso l’umanesimo visivo che esploderà poi col Rinascimento.